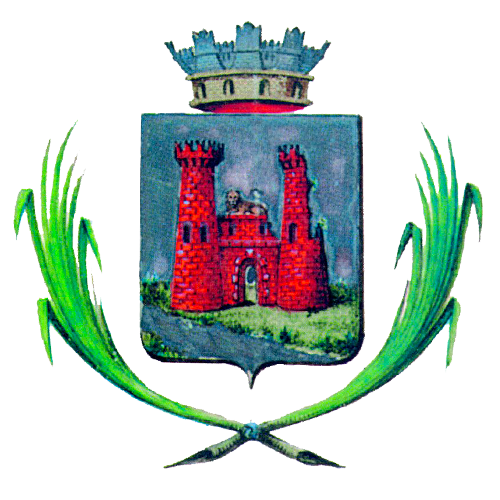Panaro, sentiero del tempo – San Cesario
Panaro nostro: la comunità e il fiume
Il Panaro è un punto di riferimento per le comunità che abitano le campagne e i paesi sorti lungo il suo corso. Nei secoli, tra l’ambiente fluviale e le persone si forma una relazione complessa e dinamica, perché l’acqua spesso dà e a volte toglie. Le donne e gli uomini conoscono il fiume, sanno leggere i cambiamenti delle stagioni e interpretare i pericoli delle piene.
Risorsa e calamità: Panaro può essere entrambe le cose, anche nell’arco di pochi mesi. Quando scorre con impeto, la corrente trascina verso valle tronchi e rami, che diventano legna da recuperare e da ardere nei focolari delle persone più povere. In mancanza d’altro, bastano anche i bacarlot, pezzetti di legno depositati sulla riva dalla corrente: molti braccianti, induriti dalle fatiche e immiseriti dalle disuguaglianze, intiepidiscono la loro stanza solo recuperando questi frammenti.
I sassi e le sabbie sono la materia prima dell’architettura contadina: chi ha bisogno di costruire arriva in alveo con l’asino e il biroccio, poi preleva ciò che serve con la forza delle braccia. Nessuno sottrae al fiume più di quello che può estrarre con l’energia dei corpi umani e trasportare col lavoro degli animali. Così, nel tempo, le acque ristabiliscono un equilibrio, depositando a valle e in pianura i sedimenti erosi a monte.
Panaro è un ecosistema vivo: chi ha fame, ma non ha carne da mangiare, s’ingegna a pescare là dove le acque sono più generose. E nei punti più stretti, dove le rive sembrano guardarsi, si aprono i guadi, esposti alla luce nei tempi di magra e solcati dai barcaioli quando dominano le acque. Proprio lungo quelle linee, cuciture umane tra le rive, gli ingegneri dell’Ottocento immaginano ponti e strade, per portare anche in provincia i vantaggi di un attraversamento carrabile sull’asciutto. I cantieri si aprono prima a Vignola e poi a Spilamberto, garantendo lavoro a chi fatica a guadagnarsi da vivere.
I piloni e le arcate cominciano a cambiare il paesaggio fluviale. Sopra i ponti passa la modernità delle tranvie e delle linee ferroviarie, che accorciano le distanze e semplificano le vite di chi può permettersi il biglietto per il viaggio. Sotto i binari, sul pelo dell’acqua, il tempo scorre ancora lento, scandito dalle fatiche delle lavandaie e dai giochi dei bambini.
Il Novecento porta con sé le speranze del progresso e le ambizioni del nazionalismo, mobilitando anche il Panaro e il suo ambiente. Sulle spiagge di ciottoli nascono colonie elioterapiche, dove i figli delle città prendono il sole e fanno ginnastica in divisa fascista per diventare una nazione guerriera. Passano pochi anni e quel delirio di onnipotenza si traduce nel disastro della Seconda guerra mondiale: il fiume diventa una traccia di volo per gli aviatori anglo-americani, pronti a colpire i ponti e le postazioni delle forze armate tedesche. Panaro è, al tempo stesso, uno spazio vitale per la Resistenza, perché nasconde i passi clandestini di chi si batte per un mondo nuovo.
Nel 1945 la Liberazione arriva insieme alla primavera e tante persone sognano di costruire la giustizia. È dura, specialmente nei primi anni del dopoguerra, ma poi lo sviluppo economico cambia le vite di molti. La tecnologia genera ricchezza e il potere d’acquisto si allarga. Comincia la grande trasformazione: cambiano i ritmi di vita, accelerati dai motori, e le forze del lavoro, moltiplicate dalla chimica. Il progresso si mette in marcia sfruttando senza misura le risorse naturali e imprimendo sull’ambiente i segni dell’inquinamento. La relazione secolare tra il Panaro e le comunità cresciute sulle rive si allenta, si sfrangia e si smarrisce fino al punto di rottura. Nel frattempo nascono, tuttavia, nuove idee, che aprono a uno sviluppo sostenibile e legano il benessere umano alla speranza di una riconciliazione con la natura. Camminare lungo il percorso della memoria significa muovere i propri passi per generare un nuovo rapporto col fiume e con i suoi spazi.
Sbarcare il lunario insieme al fiume
L’agricoltura di San Cesario è figlia del Panaro. Nella storia, prima dell’Ottocento, il fiume scorre in un alveo molto ampio e deposita i sedimenti delle piene nelle campagne della pianura. I terreni più vicini al flusso delle acque sono i più ricchi di sostanze organiche. La fertilità è delizia, ma le piene sono croce: chi coltiva quei campi sa che il raccolto è abbondante, ma scopre anche che all’improvviso Panaro può riprendersi le terre in cui si espandeva per secoli, sommergendo in poche ore tanti mesi di fatiche. Diversa è la sorte dei contadini che coltivano i terreni lontani dal fiume: le piene li risparmiano, ma l’acqua del Panaro non potrebbe raggiungere i loro campi se la comunità non avesse concepito e realizzato un apparato circolatorio artificiale. Tra il Basso Medioevo e l’età contemporanea, l’ingegneria idraulica e le braccia degli sterratori danno vita a una rete di canali e fossi, chiuse e paratoie, bocchette di derivazione e canalette irrigue, per portare i benefici del fiume a chi è troppo lontano dalla corrente.
L’arteria principale è il canale Torbido, una via d’acqua millenaria, realizzata nel corso del Medioevo per unire Savignano sul Panaro e Nonantola. Da lì il corso artificiale si spinge ancora oltre nella pianura, fino a raggiungere il Panaro nei pressi di Finale Emilia. Attraverso i secoli, il Torbido permette di irrigare le campagne di San Cesario e di impiantare anche diverse risaie, in particolare nei poderi della Graziosa e della Battistecca. Le acque non sono, però, soltanto fonte di vita, ma anche di liti: sulle sponde del canale sorgono mulini, cartiere e impianti per la lavorazione dei tessuti, che si servono della corrente per dare energia alle macchine. Nei tempi di magra, chi ha il diritto di aprire le bocchette per sfruttare l’acqua? Nessuno vuole rimanere a bocca asciutta e tutti vogliono che il canale funzioni al meglio, ma da soli non possono accollarsi le manutenzioni. Così, di fronte ai problemi e alle difficoltà economiche, gli agricoltori e i conduttori degli opifici si uniscono in consorzi per gestire insieme la situazione. Le contese non finiscono, ma diventa più semplice individuare obiettivi comuni e raggiungere accordi.
Gli scenari del fiume e delle campagne cambiano più rapidamente a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, quando le comunità cercano di contenere gli effetti delle piene per stabilizzare il popolamento dei territori vicini ai fiumi e assicurare continuità alle attività economiche. Inizia un’epoca scandita dai cantieri delle opere pubbliche: gli argini irreggimentano i corsi delle acque e ridisegnano il paesaggio, mentre i moli e i pennelli deviano la corrente per preservare le rive dall’erosione. Accanto ai tradizionali muri e terrapieni, eretti con materiali recuperati sul posto, compaiono sempre più spesso i gabbioni, formati da reti metalliche piene di sassi e ciottoli. Per costruire tutte queste opere, generazioni di terrazzieri si affaticano in cambio di un temporaneo sollievo alla disoccupazione. Le autorità provinciali e municipali incoraggiano gli interventi, perché la miseria che tormenta i lavoratori avventizi è una minaccia per la pace sociale: chi non sa come guadagnarsi il pane finisce per vivere di espedienti o per incoraggiare le rivolte. I cantieri degli argini si riempiono di persone disposte a tutto pur di ricevere un salario, ma anche di voci che invitano i compagni a battersi per la giustizia sociale. Nascono, così, le leghe dei braccianti e le cooperative dei terrazzieri, che si mettono insieme per ricavare forza dall’unione.
Gli argini ridisegnano l’alveo del Panaro, forzato a scorrere in un letto più stretto per preservare le coltivazioni dei campi. Nel frattempo, il progresso lascia anche altri segni sul territorio: le strade si diramano sempre più capillarmente e cresce il bisogno di ghiaia. Il fiume ne offre a volontà e i birocciai s’ingegnano per recuperarne quanta più possibile, ma i loro mezzi non reggono i ritmi sostenuti dai frantoi, costruiti in gran numero lungo entrambe le rive del fiume. Nel corso degli anni, gli impianti per la lavorazione delle sabbie e delle ghiaie diventano veri e propri stabilimenti industriali, capaci di trattare quantità di materiali notevolmente superiori a quelle dei decenni precedenti. La produttività dei frantoi incoraggia l’estrazione in alveo, resa ancora più urgente dal cantiere dell’Autostrada del Sole e dall’espansione edilizia nell’era del miracolo economico.
L’irruzione dello sviluppo tecnologico trasforma definitivamente i mestieri del fiume: i cavalli lasciano progressivamente il posto ai camion e le braccia dei cavatori vengono rimpiazzate dalle ruspe. Così, Panaro diventa una vena aperta: gli scavi trasformano il corso del fiume, rendendo più veloce la corrente. L’acqua scivola via sempre più rapida, depositando pochi detriti e scavando con impeto il percorso più rapido verso la pianura. Il fiume erode il proprio letto e le rive che lo contengono, facendo emergere le argille che custodiscono fossili della preistoria e testimonianze archeologiche. Gli scavi arricchiscono le conoscenze del passato in un’epoca che, dopo anni vissuti nell’illusione di un progresso senza ombre, s’interroga sul futuro del Panaro: come potranno il fiume e i canali sopravvivere all’inquinamento provocato dalle attività produttive e dagli scarichi dei centri abitati? Per quanto tempo ci saranno ancora sassi, se si continuerà a scavare con mezzi così rapidi e potenti?
Istituzioni, associazioni e cittadini cominciano a mobilitarsi per salvare l’ambiente del fiume. Mentre si approvano leggi per colpire chi inquina, si cerca di contenere anche il problema dell’erosione, assicurando al tempo stesso le materie prime per l’edilizia: gli scavi in alveo si fermano, ma nelle vicinanze del Panaro si aprono diversi poli estrattivi, concessi a imprese che s’impegnano a risanare i terreni al termine dell’utilizzo. Nella zona in cui si snoda questo percorso, le attività estrattive si fermano prima del 2013. Comincia, poi, un processo di recupero dell’area come zona di riequilibrio ambientale, destinata ad accogliere le persone che vogliono rientrare in contatto con gli spazi del fiume.
I martiri del Panaro
Nei venti mesi dell’occupazione nazista e del fascismo repubblicano, San Cesario sul Panaro fa parte della Quarta zona partigiana modenese, insieme a Castelfranco Emilia e alle sue frazioni. Le campagne lungo la riva destra del Panaro sono fondamentali per nutrire e sostenere l’organizzazione della Resistenza. Il Comitato di liberazione nazionale invita le famiglie contadine a intraprendere forme di lotta nonviolenta, nascondendo il cibo destinato a sostenere lo sforzo bellico nazi-fascista e ostacolando i piani delle autorità occupanti. Le formazioni partigiane s’impegnano a non ingaggiare scontri armati per non attirare le attenzioni dei tedeschi, favorendo così il trasferimento di viveri e rifornimenti alle brigate attive in montagna.
Tra l’estate e l’autunno del 1944 i partigiani aiutano i contadini nella difesa del bestiame, bloccando le requisizioni naziste e ostacolando le razzie delle milizie che collaborano con le forze occupanti. Queste azioni consolidano i rapporti tra la Resistenza e i lavoratori delle campagne. Gli organizzatori della lotta partigiana confidano che gli anglo-americani continuino ad avanzare verso nord e si preparano a insorgere per conquistarsi la Liberazione prima dell’inverno. Accolgono, così, nuovi volontari nelle formazioni, coinvolgendo persone meno preparate ad affrontare la vita in clandestinità. La situazione si complica tra ottobre e novembre, quando le forze armate anglo-americane rimangono bloccate a sud della Linea Gotica e il piano dell’insurrezione generale si rivela inattuabile. Mentre si profila il secondo inverno dell’occupazione nazi-fascista, le formazioni partigiane sono troppo numerose per poter restare nelle basi di pianura. Diventa sempre più difficile anche assicurare il cibo e gli indumenti ai volontari della Resistenza. Contestualmente, la fine delle operazioni militari lungo la Linea Gotica permette ai nazisti e ai fascisti di concentrare le forze contro i partigiani e le comunità che li sostengono. Nelle campagne tra Modena e Bologna, l’attività delle spie consente di individuare alcuni nuclei organizzativi della Resistenza, creando le condizioni per una serie di attacchi sul territorio. Tra il pomeriggio del 13 e l’alba del 14 dicembre, le campagne della quarta zona partigiana modenese sono investite da un massiccio rastrellamento: grazie alle indicazioni ricevute da delatori fascisti, la Compagnia Scorta Divisionale, la 5a Batteria del III reggimento d’artiglieria della 16a Panzergrenadier-Division "Reichsführer-SS" e i militari del locale presidio tedesco arrestano una settantina di persone e le conducono nell’ammasso canapa di Castelfranco. Lì si svolgono i primi interrogatori, nel corso dei quali le spie fasciste indicano ai tedeschi i civili da rilasciare e i partigiani da trattenere. Sigialfredo Baraldi, Gabriella Degli Esposti, Gaetano Grandi, Ettore Magni, Annibale Marinelli, Livio Orlandi, Roberto Pedretti, Dino Rosa, Lucio Pietro Tosi, Mario Tosi, Ezio Zagni e Riccardo Zagni vengono rinchiusi nei locali dell’ammasso, dove vengono ripetutamente torturati. Riccardo Zagni è falciato nel cortile dell’ammasso canapa il 16 – o, secondo altre fonti, il 18 – dicembre. All’alba del 17, gli altri ostaggi – tranne Mario Tosi – sono condotti già agonizzanti a Ca’ Nova e vengono fucilati sul greto del Panaro. I corpi vengono riesumati il 26 gennaio 1945. Mario Tosi è costretto a seguire le SS nel bolognese per prelevare denaro da un libretto di banca che aveva con sé al momento dell’arresto; il 20 dicembre, compiuta la missione, i militi nazisti lo uccidono lungo la Porrettana.
Gabriella Degli Esposti
Gabriella Degli Esposti nasce il 1° agosto 1912 a Calcara di Crespellano (BO), in una famiglia molto povera. La sua vita conosce una svolta a poco più di vent’anni, quando sposa Bruno Reverberi e si trasferisce nelle campagne di Castelfranco Emilia. Lì comincia a gestire insieme al marito un piccolo caseificio. Le difficoltà non mancano: alla metà degli anni Trenta l’economia italiana imbocca una parabola discendente che il regime non riuscirà più a invertire. Basterebbe quello scenario di crisi a complicare la gestione di un’azienda familiare… ma per Gabriella e Bruno la situazione è ancora più dura. Il motivo? L’antifascismo.
Bruno non ha mai nascosto la sua ostilità per il Duce e per la dittatura. Col passare del tempo anche Gabriella matura un sentimento antifascista tanto prepolitico quanto profondo. Come tante donne della sua generazione, non si è mai occupata di politica. Eppure, quello che vede nel suo mondo non la convince e non le piace. Quando cominciano le guerre del regime, per i contadini ogni sfida del quotidiano diventa ancora più difficile, anche crescere Savina e Liduina, le due bambine che ha messo al mondo insieme a Bruno.
Poi, quasi all’improvviso, arriva una seconda svolta. È lo sconquasso dell’8 settembre 1943, quando le campagne di Castelfranco si riempiono di soldati in fuga. Bruno e Gabriella li accolgono, donano loro abiti borghesi e li salvano dalla prigionia. Da quell’aiuto alla lotta contro i nazisti e i fascisti il passo non è sempre automatico, ma questi due coniugi lo fanno di slancio. Gabriella entra nella Brigata “Walter Tabacchi” già il 19 settembre, scegliendo “Balella” come nome di battaglia. Nei mesi successivi agisce come staffetta, tenendo i collegamenti tra i partigiani di Castelfranco e le organizzazioni della provincia modenese. Insieme a Bruno mette la propria casa a disposizione della Resistenza, ma alla fine del 1944 su quelle campagne si concentrano le attenzioni dei fascisti e dei nazisti.
Nel pomeriggio del 13 dicembre i nazisti cominciano un rastrellamento nelle frazioni di Castelfranco con l’obiettivo di snidare i partigiani della Quarta zona modenese. Alcuni militari si presentano a cercare Bruno, ma trovano Gabriella, incinta di sei mesi; lei li allontana con un espediente, poi affida le bambine ai vicini. Poche ore dopo, i nazisti arrivano ad arrestarla.
Gabriella viene condotta all’ammasso canapa, dove si trovano anche gli altri ostaggi, catturati nel corso della giornata. Nei due giorni successivi viene torturata e seviziata. Poi, all’alba del 17 dicembre, i nazisti la caricano su un mezzo diretto a Ca’ Nova, sul greto del Fiume Panaro. È già in fin di vita e la uccidono con un colpo alla nuca insieme ad altri 9 ostaggi dell’ammasso canapa: Sigialfredo Baraldi, Gaetano Grandi, Ettore Magni, Annibale Marinelli, Livio Orlandi, Roberto Pedretti, Dino Rosa, Lucio Pietro Tosi ed Ezio Zagni. Poi scavano una fossa sulla riva del Panaro e li seppelliscono insieme. Coprono tutto con poca terra, forse per fretta o per noncuranza. Il 26 gennaio 1945 qualcuno segnala la presenza di resti umani nei pressi del fiume: alcuni cittadini di San Cesario procedono alla riesumazione dei cadaveri. Per le celebrazioni, la medaglia d’oro al valor militare e i racconti della memoria ci sarà tempo soltanto dopo la Liberazione…
Bibliografia
- Aa. Vv., 55 anni. Sempre giovani, San Cesario sul Panaro, Associazione Osteria della Graspa, 2017.
- Aa. Vv., L’uomo e il Panaro. Cent’anni di frequentazione del fiume attraverso la fotografia, Vignola, Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna - Mario Menabue, 1994.
- Gabriella Corona, Breve storia dell'ambiente in Italia, Bologna, Il Mulino, 2015.
- Guido Crainz, Il Paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta, Roma, Donzelli, 2003.
- Guido Crainz, Padania: il mondo dei braccianti dall'Ottocento alla fuga dalle campagne, Roma, Donzelli, 2007.
- Daniel Degli Esposti, Lottare per scegliere. Antifascismo, Resistenza e ricostruzione a Spilamberto, Modena, Artestampa, 2018.
- Roberto Fiorini, Quando lento scorre il fiume: dentro l'autobiografia e la storia, San Cesario sul Panaro, Osteria della Graspa, 2000.
- Marco Golfieri, Renzo Pellicciari e Fausto Rosi (a cura di), San Cesario. Cartoline, fotografie e documenti, Spilamberto, El Quater’Ari, 1989.
- Giampaolo Grandi (a cura di), Con la forza dell'acqua: storie d'acque, di opifici, di lavoro e di uomini sul Canale di Marano, di S. Pietro, del Diamante, sul Canalino Castellano, sul Torbido, Vignola, Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna - Mario Menabue, 2010.
- Giuliano Muzzioli, L'economia e la società modenese fra le due guerre: 1919-1939, Modena, STEM, 1979.
- Giuliano Muzzioli, Modena, Roma-Bari, Laterza, 1993.
- Luca Pastore, Il fascicolo 663: un processo atteso per sessant'anni: la Resistenza a Castelfranco Emilia, l'eccidio nazifascista del dicembre 1944 e le carte occultate nell'armadio della vergogna, Castelfranco Emilia, ANPI, 2008.
- Renzo Rabacchi, Enzo Cavani e Giuliano Tosatti (a cura di), Panèra: guida all'ambiente del fiume Panaro, Savignano sul Panaro, Grandi e Grandi, 2009.
- Savina Reverberi Catellani, Gabriella Degli Esposti mia madre: storia di una famiglia nella tragedia della guerra, Modena, Artestampa, 2022.
Si ringraziano Osteria della Graspa, Paola Bortolotti, Ulisse Maccaferri, Paolo Pellicciari e Luciano Rosi per i materiali bibliografici e fotografici cortesemente forniti, che hanno rappresentato risorse preziose per la realizzazione del progetto. Si ringrazia anche il laboratorio di podcast Voci in Campo per il supporto nella realizzazione dell’audio-guida.
Audioguida "Panaro nostro: la comunità e il fiume"
Audioguida "Sbarcare il lunario insieme al fiume"
Audioguida "I martiri del Panaro"